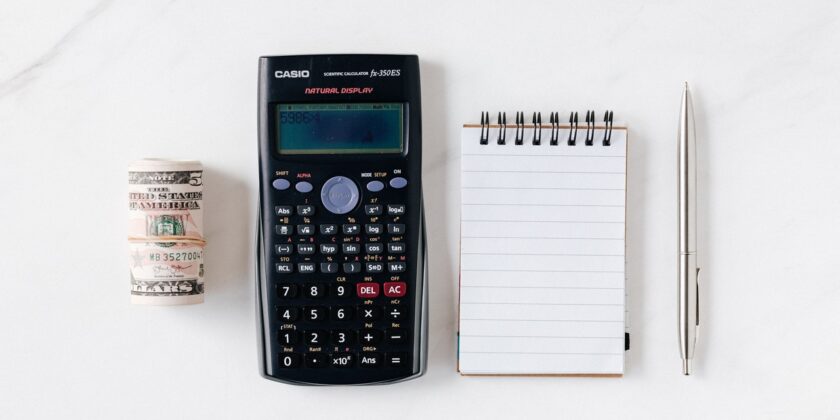È possibile ridurre il debito pubblico di un Paese, calcolato in rapporto al PIL, solamente puntando su un aumento della crescita economica? Oppure, per farlo, è necessario adottare obbligatoriamente delle politiche di austerità di bilancio, ovvero ricorrendo ad un mix di taglio della spesa pubblica e di aumento delle tasse? La domanda, come si può ben intuire, è di fondamentale importanza nell’analisi dell’economia odierna dei paesi occidentali, considerando che, soprattutto dopo la crisi pandemica, i debiti della maggior parte di questi hanno registrato aumenti percentuali a doppia cifra. Negli Stati Uniti, ad esempio, il rapporto debito/Pil ha toccato il livello record del 133,9% nel 2020, in netto aumento rispetto al 108,4% dell’anno precedente.
Leggermente meglio è andata nell’Eurozona, dove il rapporto, sempre nel 2020, ha toccato il livello record pari al 97,5%, in aumento rispetto all’83,7% dell’anno precedente. In entrambe le macroaree economiche, le previsioni sono di una riduzione dei rispettivi rapporti nei prossimi anni, ma questa sarà soltanto graduale e, per raggiungere i livelli pre-pandemici, occorrerà attendere almeno un decennio. Sempre nell’ipotesi ottimistica che la crisi pandemica possa risolversi nel giro dei prossimi mesi. In caso contrario, i tempi del ritorno alla situazione precedente si allungherebbero di molto.
Sembrerebbe che gli Stati indebitati siano condannati a seguire politiche di bilancio restrittive per i prossimi anni
L’evidenza empirica che abbiamo a disposizione sull’efficacia delle strategie di riduzione del debito pubblico attuate dagli Stati nei decenni passati, purtroppo, non fornisce risultati confortanti sulla validità dell’approccio di policy-making che punta tutte le sue carte sull’aumento del denominatore del rapporto debito/PIL. Uno studio compiuto da Sofia Bernardini, Carlo Cottarelli, Giampaolo Galli e Carlo Valdes dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano nel 2019 ha analizzato 30 episodi di riduzione del debito superiore a 25 punti percentuali condotti dai governi nelle economie avanzate dopo la Seconda guerra mondiale, giungendo alla conclusione che l’unica strategia di riduzione del debito che ha avuto storicamente successo tra tutte quelle analizzate è stata quella che ha puntato a ridurre l’avanzo primario (differenza tra entrate e spese calcolata al netto della spesa per interessi sul debito) in maniera sufficientemente ampia.
Lo studio conclude anche che, invece, le strategie di riduzione del debito basate sull’adozione di politiche di bilancio espansive, ovvero praticate tramite un aumento della spesa pubblica o una riduzione delle tasse, nella speranza di mettere in moto la crescita economica e, quindi, di aumentare il denominatore del rapporto, non ha mai raggiunto gli obiettivi sperati.
Se si guardasse unicamente alle conclusioni del paper, sembrerebbe che gli Stati indebitati siano condannati a seguire politiche di bilancio restrittive per i prossimi anni, se non decenni, nell’intento di riportare il livello del debito ad un livello accettabile (sulla questione del livello “accettabile” di rapporto debito/PIL il dibattito accademico è ampio e articolato e richiederebbe ben più di un articolo per discuterne le varie posizioni).
Il rischio è così quello che una stretta di bilancio possa provocare effetti di riduzione del PIL e, quindi, di entrare in una spirale deflazionistica dagli esiti incerti.
Certamente, l’evidenza sulla riduzione del debito dovrebbe insegnare, in ogni caso, che la responsabilità di bilancio è un asset fondamentale di cui ogni Paese si dovrebbe sempre dotare. Questa responsabilità dovrebbe esortare i policy-maker a favorire la spesa in conto capitale, relativa agli investimenti, rispetto alla spesa corrente, nella quale spesso si annidano le inefficienze e gli sprechi.
La qualità della spesa e le scelte allocative compiute su di essa producono effetti diversi, tanto sulle finanze pubbliche che sulla crescita economica. È indubbio, infatti, che la spesa per investimenti sia maggiormente in grado di aumentare la dotazione di capitale, fisico e umano, di un Paese e, quindi, il suo potenziale di crescita di lungo periodo, con effetti positivi sulla base imponibile, sul gettito fiscale e contributivo. Al contrario, la spesa corrente non sembra avere gli stessi effetti virtuosi e, di conseguenza, dovrebbe essere più soggetta ad un rigoroso controllo (“spending review”), con l’adozione di tetti alla sua crescita annuale.
Molte scuole di pensiero hanno a lungo sostenuto che, dopo la crisi finanziaria del 2008, l’economia globale fosse entrata in una epoca dove i tassi d’interesse reali e i livelli di inflazione sarebbero entrambi rimasti ai loro livelli minimi per i successivi decenni. La recrudescenza inflazionistica post-Covid e il ragionevole rialzo dei tassi d’interesse che a breve ne conseguirà, fa comprendere la fallacia di quelle teorie e la conseguente necessità di ripensare ad un nuovo equilibrio tra politiche per la crescita e di controllo della disciplina del bilancio. Sempre guardano all’evidenza storica che è sempre la miglior maestra per coloro che prendono decisioni di politica economica.